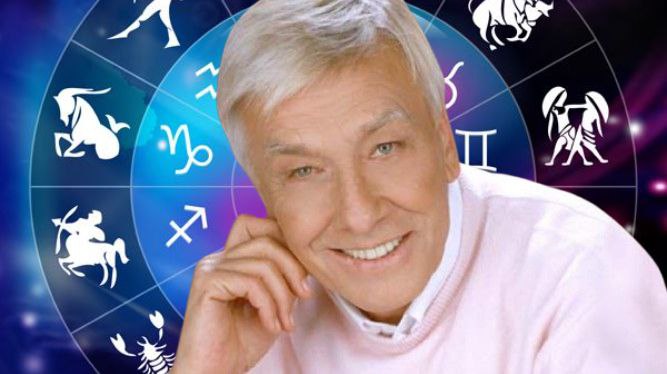Il tempo della giustizia è un tempo strano: la “famiglia nel bosco” e un Natale che non assomiglia a nessun altro
Il tempo della giustizia è un tempo strano, un tempo che scorre in modo diverso rispetto a quello delle famiglie. Non è una frase fatta, non è un modo elegante per dire che le cose vanno lente. È proprio un’altra velocità, un’altra metrica, un altro ritmo interiore. La giustizia misura con strumenti che non conoscono la domenica, non conoscono l’odore del sugo che cuoce, non conoscono l’ansia di un bambino che guarda la porta e aspetta un passo preciso. La giustizia non ha nostalgia. Le famiglie sì.

In questi giorni che precedono il Natale, mentre fuori si organizzano viaggi, si incartano pacchi, si contano i posti a tavola e si finge, a volte, una serenità che non c’è, una coppia anglo-australiana vive un’attesa che ha un sapore diverso da qualsiasi altra attesa. Nathane e Catherine, ribattezzati dai media la “famiglia nel bosco”, sono diventati un simbolo difficile da maneggiare. Per alcuni incarnano una scelta estrema, per altri un fallimento istituzionale, per altri ancora una storia che mette a nudo le contraddizioni del nostro modo di intendere tutela, libertà, genitorialità.
Quando un caso diventa simbolo, succede una cosa crudele: le persone reali spariscono. Restano le parole, restano gli schieramenti, restano i commenti urlati. Eppure, dietro quel titolo che funziona, dietro quella definizione che sembra uscita da un romanzo contemporaneo, ci sono tre bambini e due genitori che cercano di capire cosa significa, davvero, “il bene dei minori” quando quel bene viene misurato da un tribunale e non da un abbraccio.
Natale, cioè il momento in cui la distanza pesa il doppio
Il Natale è un amplificatore emotivo. Lo è per tutti, anche per chi sostiene di odiarlo. Accende la memoria, mette in fila le assenze, rende più evidente ciò che manca. Se sei separato, se hai perso qualcuno, se ti senti fuori posto, Natale non perdona. E se sei un genitore che non può passare le feste con i figli, Natale diventa una specie di rumore di fondo che non smette mai.
Nathane e Catherine, in queste settimane, non chiedono un ritorno improvviso alla normalità. Non chiedono la cancellazione del passato. Chiedono, almeno così raccontano i loro legali, qualche ora in più. Un tempo in più. Anche sotto supervisione. Anche dentro un contesto controllato. Chiedono un Natale che somigli almeno un po’ a ciò che, per loro, il Natale dovrebbe essere: stare con i propri bambini.
Ed è qui che si sente lo strappo. Perché la giustizia, di fronte a questa richiesta, non risponde con la logica dell’eccezione emotiva. Risponde con la logica della prudenza. E la prudenza, quando arriva a dicembre, suona come una porta che si chiude proprio mentre tutti intorno accendono luci.
La decisione della Corte d’Appello dell’Aquila e la parola che pesa: prematuro
Nei giorni scorsi, tra il 19 e il 20 dicembre 2025, la Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il reclamo presentato dai legali della coppia contro l’ordinanza che sospende la responsabilità genitoriale. È un passaggio che, detto così, sembra freddo. Ma dentro quel linguaggio c’è un mondo. Significa che, per ora, i tre minori restano nella struttura protetta a Vasto dove sono stati collocati dopo il provvedimento del Tribunale per i minorenni, che a partire dal 20 novembre 2025 ha disposto l’allontanamento dalla casa rurale in cui vivevano.
Il punto non è solo la permanenza in casa famiglia. Il punto è l’idea che un ritorno, anche parziale, anche festivo, venga considerato prematuro. Prematuro è una parola strana, perché non dice mai quanto bisogna aspettare. Dice solo non adesso. E quando non adesso coincide con il Natale, quella parola sembra diventare più dura, quasi inevitabilmente.
I giudici hanno ribadito la necessità di tutelare i bambini e hanno richiamato due nodi centrali, ripetuti in più ricostruzioni: un livello di istruzione giudicato gravemente insufficiente e una socialità definita deprivata, come se i piccoli fossero cresciuti in un isolamento incompatibile con il loro sviluppo. È qui che la storia smette di essere una storia romantica di vita alternativa e diventa una domanda scomoda: quanto può spingersi una scelta di stile di vita quando in mezzo ci sono dei minori?
La tentazione di semplificare e l’errore che facciamo tutti
Quando leggiamo storie così, siamo tentati di cercare il colpevole e di sistemarci comodi. O i genitori sono mostri irresponsabili, oppure sono vittime di un sistema ottuso. È un meccanismo di difesa. Se scegliamo un colpevole, non dobbiamo più pensare. Non dobbiamo più stare nell’ambiguità. Ma l’ambiguità è il luogo dove vive la realtà.
Ci sono elementi che, letti con calma, fanno male. Un episodio sanitario citato negli atti, una bronchite acuta con broncospasmo in una delle figlie che, secondo le valutazioni riportate, non sarebbe stata segnalata né curata dai genitori. E poi la questione educativa, che in questa vicenda torna come un martello: la bambina più grande, otto anni, incapace di leggere e scrivere, con difficoltà anche nello scrivere il proprio nome, né in inglese né in italiano. È uno di quei dettagli che non si possono ignorare, perché non è un’opinione. È un indicatore concreto di ciò che è mancato.
Allo stesso tempo, c’è la vita reale che continua a scorrere. E qui il tempo della giustizia incontra il tempo della carne. Catherine, la madre, incontra i figli più volte al giorno nella struttura. Nathane, il padre, li vede con una frequenza più ridotta, due volte a settimana, mentre vive in un alloggio provvisorio, un casolare a Ortona. Questi numeri, detti così, sembrano un’agenda. In realtà sono l’ossatura emotiva di una settimana. Sono attese, preparazioni, rientri nel silenzio.
La casa famiglia, Vasto, e il peso di una parola: comunità
Quando si dice che i bambini “restano in comunità”, sembra quasi una frase neutra. Ma la comunità, nella percezione comune, è sempre un luogo di passaggio che nessuno desidera davvero. È un posto che dovrebbe proteggere, ma che racconta anche una frattura. Per i bambini può diventare una routine nuova, una normalità alternativa. Per i genitori è spesso una ferita che non si rimargina.
Eppure, il punto della tutela è proprio questo: creare stabilità dove stabilità non c’era. Garantire scuola, cure, relazioni, regole. Mettere un argine. È facile dirlo, è difficile accettarlo, soprattutto quando l’argine significa separazione.
La tutrice legale, Maria Luisa Palladino, ha indicato l’istruzione come uno dei nodi centrali che ostacolano un rientro. Non perché la scuola sia una formalità. Perché la scuola è un diritto. È il luogo dove un bambino impara a stare nel mondo. Senza, il rischio non è solo l’analfabetismo. È l’esclusione.
È qui che la storia diventa dolorosamente moderna. Perché non stiamo parlando di un passato remoto in cui la scuola era un lusso. Stiamo parlando del 2025, dell’Europa, di un contesto in cui scegliere di non educare un figlio non è più una stranezza. È una questione di responsabilità.
Gli avvocati, la contestazione, e la battaglia sulle parole
I legali della coppia, Marco Femminella e Danila Solinas, hanno espresso perplessità sulla motivazione, contestando alcuni aspetti e sottolineando che esisterebbero segnali di cambiamento. Ed è vero che nelle ricostruzioni emerse in questi giorni si parla anche di progressi, di un percorso avviato, di un tentativo di collaborazione.
Ma la giustizia ragiona su una cosa che le famiglie, spesso, faticano a tollerare: la continuità. Non basta un gesto, non basta un mese buono, non basta promettere. Serve dimostrare nel tempo. E il tempo, appunto, è ciò che fa impazzire chi sta dall’altra parte. Perché chi vive la separazione lo sente come un furto di giorni, non come un investimento sulla sicurezza.